“Sono queste persone l’anello tra il nostro catalogo ed il cliente: sono loro che possono essere il nostro punto di forza, o il nostro punto debole“

Esempio di consegna a vuoto: cassetta per la raccolta della posta scambiata per una cassetta postale
L’ha detto un importante marketing manager, responsabile per la distribuzione pubblicitaria di una grande insegna internazionale, ad un incontro di formazione degli addetti per la distribuzione di brochure e volantini.
Ad ogni campagna di distribuzione questo manager – pur molto impegnato – ha sempre ritagliato del tempo per incontrare personalmente gli operatori che sul campo dovevano consegnare il suo catalogo, ritenendo che la formazione di un gruppo di distributori è essenziale, insieme ad una buona programmazione.
Un esempio di anomalia evitabile con una buona formazione sono le cosiddette consegne “a vuoto”, quelle che implicano uno spreco di volantini, o che avvengono presso civici che il cliente richiede di non coprire: generalmente si tratta di edifici disabitati, uffici, negozi, bar, scuole, aziende, dove la distribuzione avviene comunque, nonostante l’indicazione opposta dell’insegna appaltatrice.
Segnalando una consegna a vuoto presso un ufficio, a volte l’agenzia di distribuzione replica “l’operatore non si è accorto che si trattava di un ufficio”, oppure “non ha letto il cartello”, o anche “non capisce bene l’italiano, essendo di origine straniera”. Effettivamente una svista può capitare a chiunque: è il caso della cassetta postale di uno studio su cui si legge “Avvocato Mario Rossi”, oppure “Estetista Anna Bianchi”, e chi consegna pubblicità non legge necessariamente le etichette di tutte le cassette postali.
Generalmente una consegna a vuoto non è ritenuta un’anomalia significativa, mentre il fenomeno diventa una criticità quando coinvolge tutti i negozi di una località. Ad esempio è il caso che ha coinvolto la zona delle cinque foto qui sotto:

Sono 5 tra le tante consegne avvenute presso cassette palesemente appartenenti a negozi, con vetrine grandi, cartelli evidenti, scritte ben visibili.
Perché gli addetti hanno consegnato ugualmente i volantini, nonostante l’indicazione opposta del cliente? Non avrebbero fatto meglio (e prima) a saltare questi civici?
Distribuire volantini per alcune ore, magari sotto il sole, è un lavoro impegnativo e faticoso: dopo alcune ore di distribuzione, l’addetto potrebbe aver consegnato queste copie “alla cieca” senza badare troppo a chi fosse il proprietario delle cassette postali. E’ una possibilità, ed è anche un modo per finire prima le brochure sul proprio carrello o nello zaino.
La spiegazione più semplice tuttavia è che l’operatore non sia stato formato adeguatamente sul divieto di consegna dei volantini presso i negozi. Anzi, probabilmente ha ritenuto di aver svolto un ottimo lavoro, servendo anche bar, studi, lavanderie, negozi di sci e di biancheria intima.
Invece bastava dirglielo.
Una buona formazione agli addetti che distribuiscono il materiale pubblicitario è senz’altro il modo migliore per iniziare una campagna di distribuzione. Se è vero che i distributori sono “l’anello che congiunge il catalogo ed il cliente”, è auspicabile che conoscano bene, prima di iniziare, le regole di distribuzione.
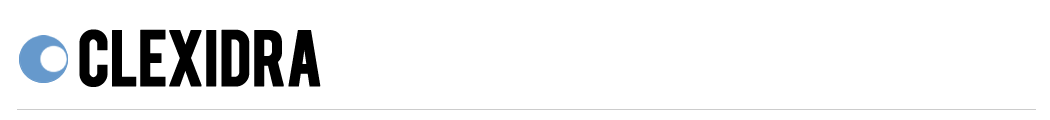

 E’ stato il T.A.R. Lombardia (Brescia, Sez. II, n. 641) che 17 aprile 2012 ha dichiarato illegittima una delibera consiliare sulla modifica al regolamento di polizia urbana in materia di volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili, verso il divieto di distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti nelle strade, piazze e spazi pubblici o aperti al pubblico, salvo determinate e restrittive condizioni.
E’ stato il T.A.R. Lombardia (Brescia, Sez. II, n. 641) che 17 aprile 2012 ha dichiarato illegittima una delibera consiliare sulla modifica al regolamento di polizia urbana in materia di volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili, verso il divieto di distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti nelle strade, piazze e spazi pubblici o aperti al pubblico, salvo determinate e restrittive condizioni. Ma quanti volantini raggiungono il destinatario e potenziale cliente? E’ stato detto che in media solo il 70% delle copie in distribuzione raggiunge una casa, e di queste soltanto il 70% viene letto; con un’ulteriore scrematura, solo il 60% dei volantini distribuiti e letti viene utilizzato per programmare un acquisto, e solo il 30% si traduce in un acquisto effettivo.
Ma quanti volantini raggiungono il destinatario e potenziale cliente? E’ stato detto che in media solo il 70% delle copie in distribuzione raggiunge una casa, e di queste soltanto il 70% viene letto; con un’ulteriore scrematura, solo il 60% dei volantini distribuiti e letti viene utilizzato per programmare un acquisto, e solo il 30% si traduce in un acquisto effettivo.
 In caso di divieto di inserimento in cassetta postale, molti distributori ricorrono allo spazio comune per la pubblicità, ovvero la cosiddetta cassetta condominiale, dedicata esclusivamente alla ricezione di annunci pubblicitari, volantini, cataloghi e brochure promozionali.
In caso di divieto di inserimento in cassetta postale, molti distributori ricorrono allo spazio comune per la pubblicità, ovvero la cosiddetta cassetta condominiale, dedicata esclusivamente alla ricezione di annunci pubblicitari, volantini, cataloghi e brochure promozionali. Comparativamente, la consegna fuori casella vede più spesso il materiale finire il proprio percorso in maniera ingloriosa: calpestato, gettato a terra o in un cestino, bagnato dalla pioggia, ignorato. Il cliente tende inoltre ad associare il volantino abbandonato davanti alla propria porta di casa con il marchio sul volantino: chi considererà scorretto e maleducato per avergli sporcato il pianerottolo con della “carta straccia” non sarà il distributore, ma il brand il cui logo campeggia sulla brochure.
Comparativamente, la consegna fuori casella vede più spesso il materiale finire il proprio percorso in maniera ingloriosa: calpestato, gettato a terra o in un cestino, bagnato dalla pioggia, ignorato. Il cliente tende inoltre ad associare il volantino abbandonato davanti alla propria porta di casa con il marchio sul volantino: chi considererà scorretto e maleducato per avergli sporcato il pianerottolo con della “carta straccia” non sarà il distributore, ma il brand il cui logo campeggia sulla brochure. La scelta delle modalità di consegna spetta innanzitutto al cliente, che ad esempio può richiedere al distributore di ignorare completamente gli spazi condominiali piuttosto che gli edifici senza cassetta, oppure può dare indicazioni precise sulle quantità da lasciare in caso di cassette comuni e portinerie. Naturalmente si può anche essere più o meno inflessibili rispetto alle consegne fuori casella: a nostro avviso, la cosa importante è essere sempre consapevoli di cosa sta succedendo, e utilizzare in modo proficuo le informazioni che si possono raccogliere sul campo tramite un controllo della distribuzione in tempo reale.
La scelta delle modalità di consegna spetta innanzitutto al cliente, che ad esempio può richiedere al distributore di ignorare completamente gli spazi condominiali piuttosto che gli edifici senza cassetta, oppure può dare indicazioni precise sulle quantità da lasciare in caso di cassette comuni e portinerie. Naturalmente si può anche essere più o meno inflessibili rispetto alle consegne fuori casella: a nostro avviso, la cosa importante è essere sempre consapevoli di cosa sta succedendo, e utilizzare in modo proficuo le informazioni che si possono raccogliere sul campo tramite un controllo della distribuzione in tempo reale.
 La raccolta di dati geografici e demoscopici è personalizzabile in base alle esigenze del cliente, ma generalmente un buon lavoro include il conteggio delle cassette postali (distinte in accessibili e inaccessibili), degli spazi condominiali per pubblicità, e anche dei cartelli “no pubblicità” e delle portinerie (di cui può essere indicato l’atteggiamento nei confronti del materiale door to door).
La raccolta di dati geografici e demoscopici è personalizzabile in base alle esigenze del cliente, ma generalmente un buon lavoro include il conteggio delle cassette postali (distinte in accessibili e inaccessibili), degli spazi condominiali per pubblicità, e anche dei cartelli “no pubblicità” e delle portinerie (di cui può essere indicato l’atteggiamento nei confronti del materiale door to door). Secondo la BBC, due persone (madre e figlio), e un altro individuo hanno ricevuto condanne fino a 18 mesi, poi sospese, dopo essersi dichiarati colpevoli di mancata distribuzione di materiale pubblicitario. I tre avevano costituito una società che avrebbe truffato più di 200 imprese: le aziende li avrebbero pagati per consegnare materiale promozionale che poi non sarebbe stato consegnato.
Secondo la BBC, due persone (madre e figlio), e un altro individuo hanno ricevuto condanne fino a 18 mesi, poi sospese, dopo essersi dichiarati colpevoli di mancata distribuzione di materiale pubblicitario. I tre avevano costituito una società che avrebbe truffato più di 200 imprese: le aziende li avrebbero pagati per consegnare materiale promozionale che poi non sarebbe stato consegnato. Questa truffa non è un caso isolato: in Europa ci sono molte aziende che sono state raggirate allo stesso modo. I truffatori costituiscono società che offrono servizi di distribuzione, ma poi non distribuiscono o distribuiscono solo una parte del materiale concordato, scartandone una percentuale più o meno ingente, che viene distrutta o rivenduta come carta da macero.
Questa truffa non è un caso isolato: in Europa ci sono molte aziende che sono state raggirate allo stesso modo. I truffatori costituiscono società che offrono servizi di distribuzione, ma poi non distribuiscono o distribuiscono solo una parte del materiale concordato, scartandone una percentuale più o meno ingente, che viene distrutta o rivenduta come carta da macero.